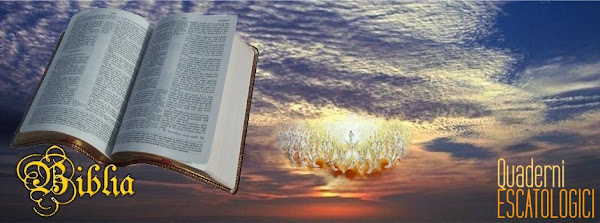Uno degli argomenti più utilizzati da atei e agnostici per dimostrare l’incoerenza della Bibbia e la stessa inesistenza di Dio è il sillogismo della schiavitù. La Bibbia approva la schiavitù; la Bibbia è parola di Dio; Dio ama la schiavitù che noi tutti, animati da un po’ di senso di giustizia, sentiamo essere una pratica abominevole. Pertanto il Dio della Bibbia se esistesse davvero sarebbe un essere estremamente ingiusto e nient’affatto misericordioso. Ecco quindi dimostrato che Dio non esiste e la Bibbia è solo parola d’uomini vissuti in un determinato contesto storico.
Uno degli argomenti più utilizzati da atei e agnostici per dimostrare l’incoerenza della Bibbia e la stessa inesistenza di Dio è il sillogismo della schiavitù. La Bibbia approva la schiavitù; la Bibbia è parola di Dio; Dio ama la schiavitù che noi tutti, animati da un po’ di senso di giustizia, sentiamo essere una pratica abominevole. Pertanto il Dio della Bibbia se esistesse davvero sarebbe un essere estremamente ingiusto e nient’affatto misericordioso. Ecco quindi dimostrato che Dio non esiste e la Bibbia è solo parola d’uomini vissuti in un determinato contesto storico.Ora, sebbene sia vero che la Bibbia non condanni esplicitamente la pratica della schiavitù, chi sbandiera il suddetto sillogismo quantomeno dimostra scarsa conoscenza dello spirito e della lettera delle Sacre Scritture. L’Antico Testamento non istituisce la schiavitù ma si limita a regolamentarla allo scopo di mitigarne la durezza e prevenire gli abusi. Per comprendere come mai Dio non l’abbia semplicemente vietata, bisogna entrare nella logica della sua relazione con l’umanità che è in realtà soprattutto relazione con i singoli uomini, con le loro coscienze, con la loro cultura e la capacità di comprendere il rapporto con la società e con il trascendente. Lo stesso popolo che Egli si scelse per essergli testimone non fu mai condotto al guinzaglio, e la stessa Bibbia, a parte il Decalogo, fu parola divina in senso molto mediato. Egli illuminava il cuore e la mente di uomini particolarmente sensibili ma comunque uomini limitati dalla loro stessa umanità e dalla cultura del loro tempo. Scopo diretto della Bibbia, parola di uomini illuminati da Dio nella misura in cui potevano accogliere la sua luce, non è mai stato quello di riformare la società ma quello di indicare la via della salvezza e di riformare i cuori. Non è che Dio sia insensibile alle ingiustizie sociali, tutt’altro, ma il metodo da lui scelto per risolvere i problemi, in questo regno che non è il suo (cf Gv 18:36), è quello di affrontarli secondo un percorso che procede dall’interno verso l’esterno. L’uomo che sperimenta il suo amore, la sua grazia e la sua salvezza, modifica il suo modo di pensare e di agire. Quando egli sperimenta il dono divino della salvezza e della libertà dalla schiavitù del peccato capisce, tra le altre cose, che è sbagliato rendere schiavo un altro essere umano.
Le prescrizioni veterotestamentarie sulla schiavitù vanno lette nel contesto della legge mosaica la quale, a sua volta, va considerata nell’ambito culturale del mondo antico. Mosè, scrittore ispirato del Pentateuco, diede agli israeliti un codice legislativo che era il punto d’incontro tra la santità dell’Eterno, i cui occhi sono “troppo puri per sopportare la vista del male” (Ab 1:13), e la miseria dell’uomo, che non riesce a resistere alla tentazione (cf Rm 7:19). Il codice mosaico si presenta pertanto come la miglior sintesi allora possibile tra la perfezione di Dio e le idee di diritto e di giustizia prevalenti in quel tempo e per molti secoli a venire. Per rendersene conto basta fare qualche confronto con le leggi degli altri popoli. La legislazione penale ebraica era decisamente più equa e umana persino di quella mesopotamica. Il famoso Codice di Hammurabi, di appena qualche secolo anteriore, prevedeva sì una pena commisurata all’offesa ma tuttavia differenziata sulla base della classe d’appartenenza dell’offeso. Si scendeva dal taglione aggravato da pene accessorie, quali la tortura e la fustigazione, alla semplice rifusione pecuniaria se l’offeso era un servo altrui. Al contrario il codice ebraico proteggeva con gran riguardo le offese contro gli schiavi sino all’applicazione del taglione. Persino l’omicidio preterintenzionale del proprio schiavo era punito, mentre se questi riportava lesioni aveva diritto alla libertà. Invece l’ordinamento romano, ben più tardo, non considerava reato l’omicidio dello schiavo se commesso dal padrone, ed era punibile solo a titolo di danneggiamento se prodotto da altri. Fa riflettere il fatto che la legge mosaica, indirizzata ad un popolo rozzo, nomade e poco strutturato, dedito alla pastorizia e appena uscito da una lunga esperienza di schiavitù, fosse ben più giusta e umana di altri codici espressione di culture decisamente più raffinate da un punto di vista economico e sociale. L’occhio esercitato dalla fede non può non scorgere in quest’apparente contraddizione la tensione verso la perfezione di Dio di una legislazione imperfetta ma in divenire. Già allora il principio del taglione, pur avanzato rispetto alla faida e a una rivalsa non regolamentata e senza proporzione rispetto all’offesa, era ulteriormente mitigato dal divieto della vendetta personale, dal comandamento dell’amore verso il prossimo (Lv 19:18) e dal dovere di carità verso i propri nemici (cf Pv 25:21). Non siamo ancora al “porgere l’altra guancia”, che peraltro neppure gli ordinamenti moderni sono in grado di recepire, ma ci sono già le premesse. Infatti la tensione verso la perfezione della legge mosaica viene disvelata quando Dio irrompe nella Storia con la missione di Cristo. Alla luce del Nuovo Testamento le regole date nel Vecchio appaiono come formule di compromesso. Primo passo di una rivelazione progressiva. Quel che Gesù disse sul divorzio (“È per la durezza del vostro cuore che Mosè scrisse per voi quella norma” – Mc 10:5), vale per la guerra, per la poligamia e, ovviamente, per la schiavitù. Svelando il carattere del Padre, Egli anticipò pure i suoi principi di giustizia che, tuttavia, neppure i suoi discepoli furono in grado di capire e quindi di accettare. Gesù dovette prenderne atto: “Non tutti capiscono questo insegnamento; lo accolgono soltanto quelli ai quali Dio dà la capacità di farlo” (Mt 19:11). Persino alla fine della sua missione, Egli dovette loro ribadire: “Ho ancora molte cose da dirvi; ma non sono per ora alla vostra portata” (Gv 16:12). Anche così Gesù svela il carattere amorevole del Padre che, per riguardo ai figli non ancora pronti a capire, rinuncia per qualche tempo alla propria volontà ideale. Anche il Nuovo Testamento deve confrontarsi con un’umanità imperfetta, dovrà tenerne conto nelle sue prescrizioni, ma al contempo le addita l’ideale che in questo mondo potrà solo essere avvicinato e mai raggiunto.
Quindi, anche se non ci si può attendere che gli scrittori del N.T. si pronuncino per l’abolizione della schiavitù, essi pongono le basi per un suo superamento. C’è un documento neotestamentario, la Lettera a Filemone, che sembra essere inserita nel Canone proprio per questo scopo. È la lettera più breve scritta dall’apostolo Paolo, l’unica indirizzata ad una singola persona e riguarda apparentemente un problema personale. Solo il tema trattato, cioè la schiavitù, può giustificare la sua presenza tra le pagine ispirate. Riassumiamola brevemente. Lo schiavo Onesimo fugge da Filemone, facoltoso cristiano della chiesa di Colosse, e si rifugia da Paolo, forse a Roma. Onesimo si converte a Cristo e diventa un fedele collaboratore dell’Apostolo. Dopo qualche tempo Paolo, che dal contesto sembra agli arresti domiciliari, rimanda Onesimo dal padrone riconoscendone in tal modo il diritto di proprietà. La Lettera a Filemone è la lettera d’accompagnamento che esorta il destinatario a non esercitare il diritto di punire lo schiavo fuggito ma, al contrario, di accoglierlo come un fratello. Paolo non chiede esplicitamente a Filemone di affrancare Onesimo dalla schiavitù, anche se gli confessa che i suoi servigi gli sono stati di grande conforto. D’altronde l’estirpazione della schiavitù dalla società greco-romana non rientrava nel suo programma apostolico. E questa prima lettura, certamente affrettata, della Lettera a Filemone ha offerto spunto ai detrattori dell’Evangelo per gridare al senso d’ingiustizia degli apostoli. Affrettata perché effettuata con la sensibilità dei giorni nostri. A noi colpisce il fatto che Paolo non dica nulla sulla schiavitù, che egli tratti Onesimo come un oggetto, sia pur desiderato, che appartiene a qualcuno, che si può spedire o offrire in dono. Il Vangelo ci è sufficientemente familiare per poterci rassegnare a ragionare in tal modo. Il modello culturale che Paolo accetta come un dato pacifico di realtà a noi invece scuote e fa paura. Se diamo ascolto a quest’impulso immediato, però, adoperiamo un metro di giudizio scorretto perché basato sul nostro attuale modello culturale forgiato su conquiste sociali peraltro abbastanza recenti. Inoltre gli esempi di moderna schiavitù che abbiamo presenti, che consistono quasi sempre in uno sfruttamento crudele e mortificante della persona assoggettata, spesso discriminata per la razza o persino per il sesso, sono fuorvianti rispetto al sistema schiavistico vigente nell’antichità. Quando fu scritta la Bibbia la schiavitù aveva più a che fare con una condizione sociale. Succedeva che le persone si proponevano come schiave quando non riuscivano a pagare i loro debiti o a provvedere alla propria famiglia. Al tempo degli apostoli, capitava di frequente che professionisti come medici, avvocati o insegnanti erano schiavi. Spesso si sceglieva questa condizione per trovare protezione e risposta ai propri bisogni. Non necessariamente pertanto la schiavitù era legata alle razzie e al bottino di guerra, né al trattamento disumano. Va poi considerato che i due terzi della popolazione nel mondo greco-romano erano schiavi; rappresentavano la quasi totalità della forza lavoro. Abolire la schiavitù era un’idea inconcepibile non solo per i padroni ma anche per molti schiavi, per buona parte dei quali l’affrancamento avrebbe coinciso con il licenziamento, con la perdita di protezione e d’ogni forma di assistenza.
Alcuni avrebbero voluto vedere nella Lettera a Filemone l’occasione opportuna per denunciare la profonda ingiustizia insita in questa pratica. Paolo li delude. Ma costoro pretendono da lui una presa di posizione anacronistica e irrealistica. Il Signore stesso non lo ha ispirato a farlo, perché verosimilmente avrebbe portato ad un bagno di sangue e all’estinzione dello stesso cristianesimo. Paolo, al contrario, si mostra rispettoso della legge, secondo uno stile che sin dalle origini ha fatto dei cristiani finché era possibile dei leali membri della società civile.
Una lettura serena della Lettera a Filemone, ci fa capire tuttavia che Paolo lavorava per svuotare di senso alla radice la pratica odiosa della schiavitù; in accordo con il metodo di Dio che non pretende raccolti immediati ma sparge semi che, innaffiati dallo Spirito, a suo tempo portano frutto. Paolo lavorava per creare delle strutture di fraternità basate sull’amore. Qui sta il punto di forza dell’Evangelo rispetto alle correnti filosofiche, ai movimenti politici, agli arruffamenti sociali, alla chiamata alle armi. Qui sta la differenza tra Paolo e un Thomas Müntzer, con le sue rivolte contadine, o un Abraham Lincoln con il suo antischiavismo opportunista e segregazionista. Paolo non era indifferente all’oppressione degli uomini che si manifestava anche con la schiavitù. Più volte nelle sue lettere aveva esortato gli schiavi a servire lealmente i loro padroni ma anche i padroni a trattare umanamente e con generosità i loro schiavi perché anch’essi avevano un “Padrone in cielo, il quale non fa distinzione di persone” (Ef 6:9). Egli non sottovalutava il dono della libertà ed infatti invitava chi aveva l’opportunità di diventare libero di avvalersene (1Cor 7:21). Ma la schiavitù dei corpi, sotto diverse forme di oppressione dell’uomo sull’uomo, era per lui un male relativo e contingente rispetto alla schiavitù della mente e del cuore, di chi resiste alla dolce signoria di Cristo. Egli esprime chiaramente questa scala di priorità, che è anche un processo di trasformazione, nella sua lettera ai Colossesi: “Ormai siete uomini nuovi, e Dio vi rinnova continuamente per portarvi alla perfetta conoscenza e farvi essere simili a lui che vi ha creati. Così, non ha più importanza essere Greci o Ebrei, circoncisi o no, barbari o selvaggi, schiavi o liberi: ciò che importa è Cristo e la sua presenza in tutti noi. Ora voi siete il popolo di Dio. Egli vi ha scelti e vi ama. Perciò abbiate sentimenti nuovi: di misericordia, di bontà, di umiltà, di pazienza, e di dolcezza” (Col 3:10-12). È anche celebre il testo parallelo di Galati: “Non esiste più né giudeo né greco, non esiste schiavo né libero, non esiste uomo o donna: tutti voi siete una persona sola in Cristo Gesù” (3:28). Le differenze etniche, le differenze sociali, le stesse differenze naturali sbiadiscono di fronte alla realtà di appartenere a Cristo. Le differenze create dagli uomini sono relative e transitorie. Egli invita pertanto gli schiavi a percepirsi in un modo nuovo, inducendoli a prendere coscienza della loro dignità di “persone affrancate in Cristo”, e ricorda al contempo ai cosiddetti uomini liberi la loro condizione di “schiavi di Cristo” (cf 1Cor 7:22). Ma se le discriminazioni e le soggezioni stabilite dagli uomini sono transitorie, la schiavitù delle menti e dei cuori produce effetti per l’eternità. È questa soprattutto che l’Apostolo teme. Quando prende forma nelle ideologie che promettono una falsa libertà: «Voi siete stati riscattati a prezzo; non diventate schiavi degli uomini» (v. 23). «Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi; state dunque saldi, e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù!» (Gal 5:1). E che finiscono, come osservò l’apostolo Pietro, per precipitare nei vizi della carne: “Promettono libertà, ma in realtà essi stessi sono schiavi della corruzione. Perché ognuno è schiavo di ciò che lo ha vinto” (2Pt 2:19). Giustamente egli temeva la schiavitù delle passioni, del proprio egoismo, delle colpe e dei peccati, della quale ci libera solo la grazia di Cristo. Il resto è secondario, per quanto importante, e risolvibile come inevitabile conseguenza. Chi acquisisce la libertà interiore, acquisisce rispetto e considerazione per coloro che gli stanno accanto, li considera fratelli, e trova aberrante la pretesa che un uomo possa rendere schiavo un altro uomo.
Nella Lettera a Filemone noi troviamo applicata questa più profonda ricerca di libertà che non combatte frontalmente il sistema sociale, fondato sullo sfruttamento del prossimo, ma lo svuota di significato calandovi dentro una nuova categoria che è la parola d’ordine dell’Evangelo: “Ama il prossimo tuo come te stesso”. “Fa agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”. Laddove le strutture sociali tardano a cambiare, i cristiani costruiscono già al suo interno una libertà relazionale totalmente nuova basata sul sentimento fraterno. La chiave interpretativa del messaggio a Filemone la troviamo nel verso 9. Questi è debitore nei confronti di Paolo, perché tramite lui ha conosciuto l’Evangelo. L’Apostolo è per lui un padre spirituale che avrebbe l’autorità morale di imporgli le sue richieste: “Con la forza che mi viene da Cristo, potrei facilmente ordinarti di compiere quel che devi fare. Tuttavia, preferisco rivolgerti una domanda in nome dell'amore”. Ecco il segreto delle relazioni cristiane: l’amore. E in nome di questo sentimento egli chiede al fratello in Cristo Filemone di accogliere lo schiavo fuggiasco Onesimo così come accoglierebbe il vecchio Apostolo, cioè come un fratello e un amico: “Ora non accoglierlo più come uno schiavo. Egli è molto più che uno schiavo: è per te un caro fratello. È carissimo a me, tanto più deve esserlo a te, sia come uomo sia come credente” (v. 16). Nella prospettiva cristiana Filemone, che avesse deciso di trattenere o affrancare Onesimo, comunque avrebbe dovuto considerarlo “un caro fratello”, e trattarlo di conseguenza. Noi riteniamo che fu liberato perché lo ritroviamo al lavoro nella chiesa di Colosse. Ignazio, scrivendo all’inizio del II secolo, menziona un certo Onesimo “vescovo di Efeso”. È facile che si riferisca a lui. Ecco come Paolo cambiava il mondo: rivolgendosi a due credenti e ad una piccola comunità cristiana della Frigia.
“Preferisco fare appello alla tua carità”. È questa la nuova categoria di cui si serve l’Apostolo per scardinare nell’immediato la porta del cuore del suo destinatario, in prospettiva il cuore dell’intera società greco-romana. Man mano che si diffonde il cristianesimo la schiavitù appare come un’eredità imbarazzante e sempre meno difendibile. Paolo non sogna rivoluzioni per infrangere le catene delle ingiustizie sociali. Non impugna, e non ispira nessuno ad impugnare, il gladio di Spartacus per aggiungere altro sangue alle famigerate guerre servili che peraltro non produssero nessun cambiamento sociale. Non spinge i cristiani a rivendicare i propri diritti con le urla, con i ricatti e con la violenza. Lo hanno fatto altri, strumentalizzando le sofferenze altrui per soddisfare le proprie ambizioni, dimostrandosi infine egoisti e crudeli come il sistema che avevano condannato. Paolo era consapevole di vivere nel tempo del “già e non ancora”, tra la prima e la seconda venuta di Cristo. Questo mondo non è ancora la patria dei redenti, ma è tuttora il terreno incantato di Satana, una realtà imperfetta dove domina la malvagità e la corruzione, dov’è di casa l’egoismo e dove tutte le occasioni sono buone per sfruttare il prossimo; dove le strutture e i sistemi sociali sono concepiti per esercitare l’ingiustizia e l’oppressione, e dove i più sono vittime e, quando possono, pure carnefici. “Imbroglioni e imbrogliati allo stesso tempo” (2Tim 3:13). Anche quando crediamo d’essere liberi, le strutture e i sistemi in cui siamo collocati ci tengono avvinti e non ci consentono di divincolarci. Chi non accetta le regole nella migliore delle ipotesi finisce emarginato, così come avviene ai clochard. Allora Paolo dimostra un sano realismo pastorale e c’insegna a cambiare il mondo non con la contrapposizione e la denuncia ma con l’esempio, vivendo nel mondo d’oggi secondo i principi del mondo avvenire. Questa rivoluzione all’interno delle regole produce effetti sul lungo periodo, ma li produce, perché piantando l’amore di Dio nel cuore dei problemi ne fa esplodere tutte le contraddizioni. L’uso di questa categoria propria di una realtà soprannaturale, anticipazione di un mondo futuro, rende il messaggio evangelico sempre attuale, anche quando le strutture e i sistemi cambiano: si pensi alle forme di asservimento economico e ideologico che minacciano oggi l’umanità, certamente più sofisticate di quelle d’un tempo, ma che la predicazione apostolica non ha difficoltà ad individuare e a contrastare con le medesime armi.
Sorge allora la domanda: come mai con la diffusione del cristianesimo la schiavitù tardò ad essere estirpata, proseguì con dei distinguo, assunse profili meno aspri, riapparve in talune periferie del mondo cristiano sotto forme persino più crudeli che nell’antichità, si è camuffata oggidì con lineamenti più sofisticati e meno riconoscibili? Dobbiamo innanzi tutto premettere che il Cristianesimo mitigò comunque sensibilmente la condizione degli uomini sotto servitù. La condizione del servaggio è ancora assai dura nell’alto medioevo ma meno aspra rispetto a quella del mondo antico; e lo sarà ancor meno nel basso medioevo, dopo l’anno Mille. E ciò si deve proprio all’influsso del Cristianesimo che raccomandava un trattamento umano, favoriva le affrancazioni e vietava la giustizia sommaria. Il padrone non ha più il diritto di vita e di morte sugli schiavi, che devono rispondere in giudizio dei loro delitti. I servi sono dei battezzati, autorizzati a crearsi una famiglia, e spesso godono di una buona condizione economica. Possono persino possedere servi a loro volta. I loro obblighi nei confronti del signore vengono fissati dal diritto consuetudinario e non devono più ritenersi a disposizione a tutte le ore della giornata, possono pertanto disporre di spazi fisici e temporali da dedicare alle proprie attività. Tuttavia essi non sono uomini liberi e sono ancora soggetti ad una serie di gravi limitazioni. Inoltre il vecchio tipo di servaggio non è del tutto scomparso sebbene limitato ai non cristiani. Questi servi di vecchio tipo, considerati ancora delle cose dai loro padroni, per distinguerli dai servi cristiani impiegati soprattutto in agricoltura, a partire dal X secolo vengono chiamati “sclavi”, da “Slavi”, l’etnia non cristiana sottomessa da Ottone I e che da allora prevalentemente alimentò la tratta insieme ad armeni, circassi, siriaci, serbi, bulgari, soprattutto impegnati nei lavori domestici nelle magioni dei cristiani benestanti. È evidente che il mondo cristiano non è stato convertito in profondità, e quindi anche le sue riforme sono parziali e contraddittorie.
E il segno di questa contraddittorietà ce lo offre proprio l’atteggiamento della Chiesa nei confronti della schiavitù. In linea di principio essa non poteva ammetterla, per coerenza verso la propria dottrina che proclama l’uguaglianza di tutti gli uomini. Sul piano concreto però, contraddicendo se stessa, essa ha tollerato a lungo la permanenza della pratica, che comunque finì per trovare le sue giustificazioni teoriche. Così fece Agostino che la lega alla colpa del peccato originale. Prima del peccato – egli afferma – gli uomini erano uguali perché Dio li aveva creati uguali e non era necessaria un’autorità a loro esterna perché la natura umana era incline al bene e non vi erano cattivi istinti da frenare e da regolare. Ma la caduta ha talmente guastato la natura umana che si sono resi necessari dei correttivi per frenare e disciplinare le cattive tendenze. Uno di questi correttivi è lo Stato, cioè il governo di un uomo sugli altri uomini; un altro è la servitù, che pone alle dipendenze di alcuni un gran numero di uomini che non sarebbero capaci di regolarsi da soli. Secondo tale concezione sia la servitù che lo Stato rappresenterebbero al contempo una punizione del peccato e un rimedio ad esso. Pertanto “la schiavitù è sì contraria al diritto naturale, ma è legittima in quanto voluta da Dio a vantaggio degli stessi schiavi, che in questa situazione possono purificarsi dai peccati ed evitare di compiere il male” (M. Melluso, La schiavitù nell’età giustinianea, Hoepli, p.262). Da una posizione teorica così contorta non potevano che derivare comportamenti disomogenei. Da un lato essa si adoperò attivamente per le affrancazioni dei servi altrui; spesso i vescovi si recavano al mercato degli schiavi e acquistavano quelli battezzati per liberarli. Dall’altro essa non si batté con fermezza perché l’istituto della schiavitù venisse soppresso, anzi accettava di avere schiavi propri, ereditati in genere insieme ai lasciti delle proprietà fondiarie che venivano donate “cum servis et ancillis” ad esse legati. In tal caso questi non venivano quasi mai liberati. Le rare volte che ciò accadeva, i liberti ecclesiae erano sottoposti ad obblighi gravosi e perpetui “il cui inadempimento portava alla revoca della manomissione” (ib. p.265). Ma vi erano precise disposizioni che scoraggiavano la pratica dell’affrancamento. Sono soprattutto “ragioni economiche che spingono la Chiesa a limitare il numero delle affrancazioni e ad imporre formalità per gli atti di manomissione. Gli schiavi, che fanno parte del patrimonio, già consistente a quest’epoca, della Chiesa sono indispensabile manodopera per coltivare le terre, la cui estensione era notevole in alcune zone. La preoccupazione che troppe manomissioni possano spogliare la Chiesa dei suoi averi risulta evidente dalle parole degli stessi clerici. Nel più volte citato Concilium Epaonense II del 517, che vieta ai superiori dei monasteri la liberazione dei servi donati dai fedeli, viene espresso il disappunto che i monaci siano costretti a svolgere il lavoro agricolo che compete agli schiavi” (ib. p.266). Era inevitabile “la preoccupazione degli ambienti ecclesiastici, ormai pienamente integrati nel preesistente sistema economico-giuridico, basato, com’è noto, sul sistema schiavistico, per la difesa delle proprie posizioni privilegiate” (Dialogues d’histoire ancienne 28/1, Hoepli, p.73). Possiamo pertanto notare un approccio diverso nei confronti della schiavitù tra la Chiesa primitiva e quella medievale. Il primo è quello che abbiamo visto con l’apostolo Paolo che, pur non condannandola, neppure la giustificava teoricamente e di fatto l’aveva svuotata di significato: essa rimane una semplice formula, qualcosa di meramente esteriore, perché padrone e servo si trovano su un piano di assoluta uguaglianza. Un approccio quindi prudente ma non opportunista. Pure la Chiesa medievale non condanna la schiavitù, ma non per prudenza e non si batte per estirparla pur avendo la forza di farlo; anzi tenta di giustificarla teoricamente. Al contempo però operava per addolcire la condizione servile e incoraggiava l’affrancamento degli schiavi altrui. Altro elemento altamente contraddittorio, in contrasto con lo spirito del messaggio cristiano, il quale afferma l’uguaglianza tra tutti gli uomini, fu la sua tolleranza per la tratta degli schiavi non cristiani. Questo fatto non solo prolungò la persistenza della pratica per molti secoli ancora ma aprì la strada ai gravi abusi che si perpetuarono fino all’età moderna soprattutto nei territori d’oltremare.
La ragione di questo comportamento chiaramente contraddittorio ce la ribadiscono due storici cattolici, Annamaria Ambrosioni e don Pietro Zerbi: “È innegabile che la Chiesa, nella tarda antichità e nel medioevo, accettando la schiavitù, accettava anche un sistema economico-sociale che le procurava notevoli vantaggi e grandi ricchezze. Così facendo, però, la Chiesa si è compromessa col sistema nel quale si è inserita, e ciò ha limitato la sua libertà di annuncio della Parola. Tutte le volte infatti che, nella storia, la Chiesa non sa sufficientemente salvaguardare la propria libertà, e per una serie di vantaggi terreni accetta di inserirsi nelle strutture di questo mondo, finisce per compromettere la sua libertà di annuncio. Con questo non si vuol dire che la Chiesa non debba inserirsi nella realtà politica e sociale, e ricercare un'intesa con lo Stato; deve farlo, anzi, per rendere il suo messaggio comprensibile agli uomini di un certo tempo e di un certo luogo, ma deve farlo in modo da non compromettere la sua libertà. È questo un problema grave e delicato, che molto spesso nella storia non è stato risolto in modo soddisfacente. Una volta dunque che, nella tarda antichità, la Chiesa si fu inserita in quel sistema economico e sociale che le procurava ricchezze e vantaggi, non ebbe più la possibilità e la forza per annunciare, integralmente e fino in fondo, il suo messaggio di liberazione a tutti gli uomini. Nel medioevo infatti notiamo in questo campo un atteggiamento un po' oscillante: la schiavitù per certi aspetti è combattuta, per altri è accettata. Questa è una delle più importanti lezioni che il cristiano può ricavare dalla storia: il problema fondamentale della Chiesa è sempre di salvaguardare la sua libertà di annuncio, e per fare questo deve guardarsi con cura estrema soprattutto dai compromessi con il potere politico e dall'eccessivo arricchimento” (A. Ambrosioni – P. Zerbi, Problemi di storia medievale, Vita e pensiero, 1988, p. 117).
Oggi la Chiesa cattolica, ovviamente, ammette che la schiavitù viola i diritti umani fondamentali ed “è contraria al disegno di Dio” (Vaticano II, Gaudium et Spes, n° 29). Ma non bisogna dimenticare che il Magistero ufficiale della Chiesa ha approvato la legittimità della schiavitù fino a Leone XIII nel 1888! Tale legittimità venne inclusa ufficialmente nel Corpus Iuris Canonici, fondato sul decreto di Graziano, e divenne legge ufficiale della Chiesa a partire da papa Gregorio IX nel 1226. Benché in seguito alcuni papi abbiano condannato gli eccessi della schiavitù (come Paolo III nel 1537, Urbano VIII nel 1639 e Benedetto XIV nel 1741), essi non la condannarono in quanto tale. Ancora nel 1866, il sant’Uffizio dichiarava: “La schiavitù in quanto tale, considerata nella sua natura fondamentale, non è del tutto contraria alla legge naturale e divina. Possono esserci molti giusti diritti alla schiavitù e sia i teologi che i commentatori dei canoni sacri vi hanno fatto riferimento… Non è contrario alla legge naturale e divina che uno schiavo possa essere venduto, acquistato, scambiato o regalato” (Pio IX, Istruzioni, 20 giugno 1866). Il tutto partendo da una lettura decontestualizzata delle Sacre Scritture. Questa mancanza di chiarezza al suo stesso interno impedì alla Chiesa di prendere una posizione netta e univoca contro ogni forma di schiavitù, e facilitò i gravi abusi che furono perpetrati dai colonizzatori europei nei territori d’oltremare. Quando nel 1430 gli spagnoli colonizzarono le isole Canarie e ridussero in schiavitù la popolazione locale, papa Eugenio IV emise una bolla di condanna che però rimase inascoltata. Su questa linea di contestazione si posero molti coraggiosi missionari cattolici soprattutto contro le violenze compiute dai colonizzatori spagnoli nelle Americhe che, con il pretesto di convertire gl’indigeni, s’impadronivano delle loro persone per ridurle nella più crudele schiavitù. Su tutte spiccò la figura del domenicano Bartolomeo de Las Casas (1474-1566) che, oltre a incoraggiare la creazione di comunità agricole dove i nativi potessero lavorare da persone libere trattate con rispetto, si batté con determinazione presso le autorità religiose, civili e militari, e la stessa corte imperiale, per ottenere la cessazione degli abusi perpetrati dagli encomenderos (i concessionari delle terre coloniali); la sua tenacia fu premiata con la promulgazione delle “Nuove Leggi” da parte di Carlo V nel 1543 che, tuttavia, non ebbero vita lunga per la forte opposizione incontrata. Nel suo testamento spirituale, Las Casas preconizzò un severo castigo divino sulla Spagna per i crimini commessi nei territori conquistati: “Credo che a causa di queste opere empie, scellerate ed ignominiose, perpetrate in modo così ingiusto e tirannico, Dio riverserà sulla Spagna la sua ira e il suo furore, giacché tutta la Spagna si è presa la sua parte, grande o piccola, delle sanguinose ricchezze usurpate a prezzo di tante rovine e di tanti massacri”. Purtroppo non tutti gli ecclesiastici la pensavano come questo missionario domenicano. Prima di lui anche gli uomini di chiesa discutevano sul criterio aristotelico di “schiavi per natura” applicato dagli spagnoli agli indios. Dopo di lui, le gelosie e le gare tra Ordini religiosi, e l’accumulazione di ricchezze, crearono colpevoli connivenze tra il potere ecclesiastico e quello politico che aiutò a perpetuare gli abusi sulle popolazioni indigene.
E che dire di papa Niccolò V che nel 1452 ordinò al re del Portogallo di ridurre in schiavitù tutti i musulmani dell’Africa? Infatti furono proprio i portoghesi a iniziare nel XV secolo l’ignobile tratta degli schiavi africani fin dai loro primi contatti con le popolazioni nere della Guinea. A Lisbona sorse e divenne fiorente un grande emporio di schiavi del quale approfittarono largamente anche i reali di Spagna. Con la scoperta delle Americhe la schiavitù fu trapiantata dai portoghesi in Brasile, attingendo sempre al grande serbatoio dell’Africa nera. Dal commercio degli schiavi africani essi ricavarono immense ricchezze, specialmente quando anche la Spagna per le sue colonie dovette importare manodopera servile di colore da utilizzare al posto di quella indigena inadatta allo sfruttamento intensivo. Ben presto ai mercanti portoghesi si aggiunsero quelli spagnoli, francesi, inglesi e olandesi in aspra competizione tra loro ma ben sostenuti dai loro sovrani che da questo mercimonio percepivano laute royalties. Ormai tutte le piantagioni del Nuovo Mondo si sostenevano sul sudore degli schiavi negri che venivano importati a centinaia di migliaia e che per il modo in cui vennero trattati costituiscono una macchia indelebile sulla coscienza della cristianità. Considerati alla stregua di animali, furono falcidiati dalle violenze, dalle privazioni e dalle malattie. Vi fu inoltre una differenza evolutiva tra le colonie latine e quelle anglosassoni: nelle prime, ove il colonizzatore abitava senza la famiglia, fu più facile la commistione (ovvero, spesso, l’oltraggio) sessuale tra schiavisti e schiavizzati, e la conseguenza fu il meticciato che finì per modificare la composizione demografica dei territori. Nelle colonie britanniche, ove invece i colonizzatori giungevano con tutte le famiglie, la promiscuità interraziale veniva considerata una mostruosità, con il sostegno teologico delle chiese riformate calviniste, favorendo in tal modo la mentalità segregazionista e i peggiori pregiudizi razziali che hanno da sempre afflitto le colonie anglosassoni.
Anche per la rinuncia delle Chiese a prendere una posizione netta e univoca sull’argomento, l’abolizione della schiavitù fu un processo lungo, articolato, travagliato, spesso usato strumentalmente. La prima proposta per l’abolizione della “tratta dei negri” fu avanzata in Inghilterra nel 1780, ma fu respinta per ben sette volte dal Parlamento prima di trovare approvazione nel 1807, soprattutto per trarne un vantaggio politico ai danni della Francia. E ci stiamo riferendo alla sola tratta, cioè alla razzia delle popolazioni di colore in Africa e alla loro deportazione nelle colonie. Mentre delle persone già schiavizzate e dei loro figli si poteva ancora liberamente disporre. L’abolizione della tratta negli Stati Uniti risale al 1808, mentre per l’abolizione vera e propria della schiavitù in quel paese bisognerà attendere il 1865. Anche lì lo stendardo dell’abolizionismo fu molto usato in chiave strumentale, dai nordisti a danno dei sudisti. Comunque, la speranza che il divieto della tratta facesse scomparire il fenomeno per naturale esaurimento si rivelò illusoria, anche dopo la solenne condanna del Congresso di Vienna (1815), in quanto il traffico proseguì attraverso il contrabbando e i territori importatori si trasformarono in “allevatori di schiavi”. La piaga poté essere debellata solo con l’abolizione tout court della schiavitù, che avvenne nelle colonie britanniche nel 1833, in quelle francesi e olandesi nel 1848, e in quelle spagnole (Cuba e Portorico) nel 1870. Gli stati latinoamericani adottarono negli anni cinquanta di quel secolo la politica cosiddetta del “ventre libero”, per cui i figli della schiava nascevano liberi, in modo che il fenomeno si estinguesse per esaurimento. L’ultimo stato cristiano ad abolire ufficialmente la schiavitù fu il Brasile nel 1888. Solo nel 1839, cioè sei anni dopo che la schiavitù era stata abolita nelle colonie britanniche, la Chiesa condannò nettamente la tratta dei neri (ma non ancora la pratica della schiavitù in quanto tale), con una lettera “in supremo” di Gregorio XVI: “In virtù della nostra autorità riproviamo il traffico dei negri come indegno del nome Cristiano. In virtù di questa stessa autorità proibiamo e interdiciamo ad ogni ecclesiastico o laico di considerare il traffico dei negri come lecito e sotto qualsiasi pretesto di predicare o insegnare in pubblico o in qualunque altro modo una dottrina in contrasto con quella apostolica”.
Paradossalmente i movimenti d’opinione che inizialmente si levarono contro la schiavitù non furono alimentati dalle Chiese ma dal pensiero illuminista che sorse in contrapposizione alla religione. Non a caso il primo paese ad abolirla per legge fu la Francia rivoluzionaria, nel 1791; sebbene pochi anni dopo venisse ripristinata da Napoleone per compiacere la borghesia creola. In realtà il paradosso è duplice in quanto i concetti di libertà, fratellanza ed uguaglianza, dei diritti della persona, l’illuminismo li aveva mutuati dalla dottrina cristiana che, però, le Chiese non riuscivano a proclamare con vigore poiché compromesse con i poteri forti. Ma le motivazioni che sostenevano gl’ideali illuministi erano al contempo molto utilitaristiche; non a caso la schiavitù venne messa apertamente in discussione con la nascita del pensiero liberale, che intendeva così eliminare anche quest’impedimento al libero sviluppo delle forze umane produttive. Questo, nell’agone impietoso della rivoluzione industriale, avrebbe significato trasferire la schiavitù di braccia divenute formalmente libere nell’inferno della più bieca spirale produttiva. Non bisogna pertanto sorprendersi se dallo stesso ceppo illuminista (e qui sta la duplicità del paradosso) sono derivate teorie di segno tutt’altro che egualitarista, come quelle che avevano come oggetto la superiorità della razza. Pensatori illuministi come Diderot, D’Alembert e Voltaire rifiutavano l’idea che bianchi e neri discendessero da un medesimo progenitore. Lo stesso Voltaire, padre dell’illuminismo e della democrazia, non riteneva imbarazzante investire i proventi dei propri libri nelle compagnie dedite alla tratta dei negri. L’antropologo inglese Edward Tyson aveva persino individuato nei neri l’anello mancante tra l’uomo e le scimmie antropomorfe. Su queste premesse del XVIII secolo si svilupparono le dottrine ancora più radicali del XIX e del XX. Come rileva lo storico George Mosse, nel suo libro Il razzismo in Europa: dalle origini all’olocausto, i pensatori illuministi basandosi sulle teorie di Darwin (che, per amor del vero, non era affatto razzista) avevano dato una veste scientifica al razzismo. Il darwinismo sociale di Herbert Spencer altro non era che un determinismo socio-biologico. Egli sosteneva che la storia non è fatta dagli uomini (e dalla loro libera scelta) ma dalla biologia, che destina ciascuno ad occupare determinati posti nella società umana. Tali posti sono assegnati ad ognuno di noi dalla natura già alla nascita, con le inevitabili disuguaglianze e gli immancabili antagonismi. Al contempo il diplomatico francese Arthur De Gobineau, autore del Saggio su l’ineguaglianza delle razze (1853-1855) interpreta la storia umana affermando che la purezza della razza determina la capacità di sopravvivenza e di dominio sulle popolazioni inferiori, mentre il declino delle civiltà andrebbe posto in relazione con la “degenerazione” dovuta al miscuglio etnico. Secondo Gobineau, la razza bianca sarebbe congenitamente superiore alle altre incarnando le virtù nobili: amore per la libertà, onore, spiritualità. I concetti di darwinismo sociale e di superiorità della razza bianca furono ripresi dai teorici del nazismo e portati alle estreme conseguenze. Ma diedero supporto pseudo-scientifico allo schiavismo, alla segregazione razziale e persino al capitalismo selvaggio. Come dire che durante la guerra civile americana, sia gli schiavisti del Sud che gli abolizionisti del Nord (comunque segregazionisti e capitalisti “darwiniani”), poterono trarre linfa dai suddetti concetti per nutrire i loro pregiudizi. Quando l’abolizionista moderato Abraham Lincoln affermava: “Devo dire che non sono, e non sono mai stato, favorevole a promuovere in alcun modo l'uguaglianza sociale e politica tra la razza bianca e quella nera; devo aggiungere che non sono mai stato favorevole a concedere il voto ai negri o a fare di loro dei giurati, né ad abilitarli a coprire cariche pubbliche, o a permetter loro matrimoni coi bianchi; riaffermo che esiste una troppo spiccata differenza tra la razza bianca e quella negra, e che questa diversità impedirà per sempre alle due razze di vivere insieme in termini di uguaglianza sociale e politica... finché la convivenza sarà necessaria, dovrà pur mantenersi un rapporto da superiore ad inferiore, e io, come ogni altra persona ragionevole, sono ovviamente a favore del ruolo dominante della razza bianca”. Egli affermava un concetto cristiano o illuminista alla Spencer e alla Gobineau? Se poi si osserva che lo schiavismo era disfunzionale all’economia nordista, centrata sul capitalismo più selvaggio e su un’assoluta mobilità del mercato del lavoro, abbiamo detto tutto.
Al contrario di quanto teorizzato da Agostino, Tommaso ed altri Patres Ecclesiae, la schiavitù non è mai stata nella volontà di Dio. È stata tollerata, e nel frattempo regolamentata, a motivo della durezza del cuore degli uomini, ma sempre in attesa che i tempi fossero maturi per abolirla. Una luce progressiva è stata data agli uomini perché gradualmente comprendessero e si allineassero alla visone di Dio. Già con la venuta di Cristo, molte cose prima tollerate ormai non avevano più ragion d’esserlo e diventavano inaccettabili. L’apostolo Paolo, il teologo del Nuovo Testamento, ha fatto piazza pulita della legislazione e della tradizione veterotestamentaria, lasciando in piedi solo il Decalogo che è la legge eterna di Dio, l’unica che Egli scrisse personalmente. Quanto all’istituto della schiavitù, l’apostolo scelse di svuotarlo di significato anziché attaccarlo frontalmente; scelse cioè un approccio più prudente per le ragioni che abbiamo detto. Cionondimeno con il suo insegnamento egli sferrò “il colpo mortale” che avrebbe portato all’annientamento di quella mostruosa pratica. La nota amara in questa vicenda è che Dio dovette spesso servirsi di alleati innaturali per raggiungere i suoi obbiettivi perché quelli naturali si mostrarono infedeli. È la nota ricorrente in tutta la storia della salvezza. Il popolo d’Israele disattese la voce dei profeti e tradì il proprio mandato di popolo eletto al punto di corrompersi più dei popoli di cui doveva esser luce (cf. Ez 5:6). Giunse a chiedere la crocifissione del Messaggero divino venuto per salvarlo. Così il nuovo Israele, la Chiesa, disattese spesso la voce degli apostoli perché ottenebrata dai troppi interessi che aveva stabilito con quel mondo che invece aveva il mandato d’illuminare. Anche la storia della schiavitù non sfuggì a questa logica. Il Cielo dovette avvalersi della voce dei pensatori illuministi, per creare un movimento d’opinione, al fine di contrastare la pratica della schiavitù rinnovata da società nominalmente cristiane. I non cristiani svergognarono i sedicenti cristiani perché le Chiese non avevano compiuto il loro dovere. Se non fosse stato per questo pungolo esterno, forse, ancora oggi le Chiese sosterrebbero la schiavitù. Ci son voluti duemila anni ai cristiani per comprendere l’equivalenza che gli apostoli allora poterono solo suggerire: com’è vero che il peccato è schiavitù, così è altrettanto vero che la schiavitù è peccato. Una grave forma di peccato. Tutti gli uomini appartengono a Cristo che li ha “comprati a caro prezzo” (1Cor 7:23), con il prezzo del suo sangue. Nessun uomo ha il diritto di comprimere la libertà di un suo simile; e non ha altresì il diritto di frodarlo del suo salario. Chi sfrutta il lavoro altrui dovrà renderne conto: “Voi non avete pagato gli operai che mietono nei vostri campi: questa paga rubata ora grida al cielo, e le proteste dei vostri contadini sono arrivate fino agli orecchi di Dio, il Signore Onnipotente” (Gc 5:4). I primi a rispondere di questo crimine saranno proprio coloro che si fregiano indegnamente del titolo di cristiani. L’Eterno è paziente e misericordioso, ma proprio perché è il più buono dei padri non lascerà impunito chi reca sofferenza alle sue creature. “È terribile cadere nelle mani del Dio vivente!” (Eb 10:31). Ci pensino i negrieri delle nuove schiavitù, più o meno sofisticate, che flagellano oggi le terre cristiane. Così come quelle che i cristiani infliggono alle altre genti invece di portar loro le parole di misericordia e di speranza del mandato evangelico.
Lascia un commento